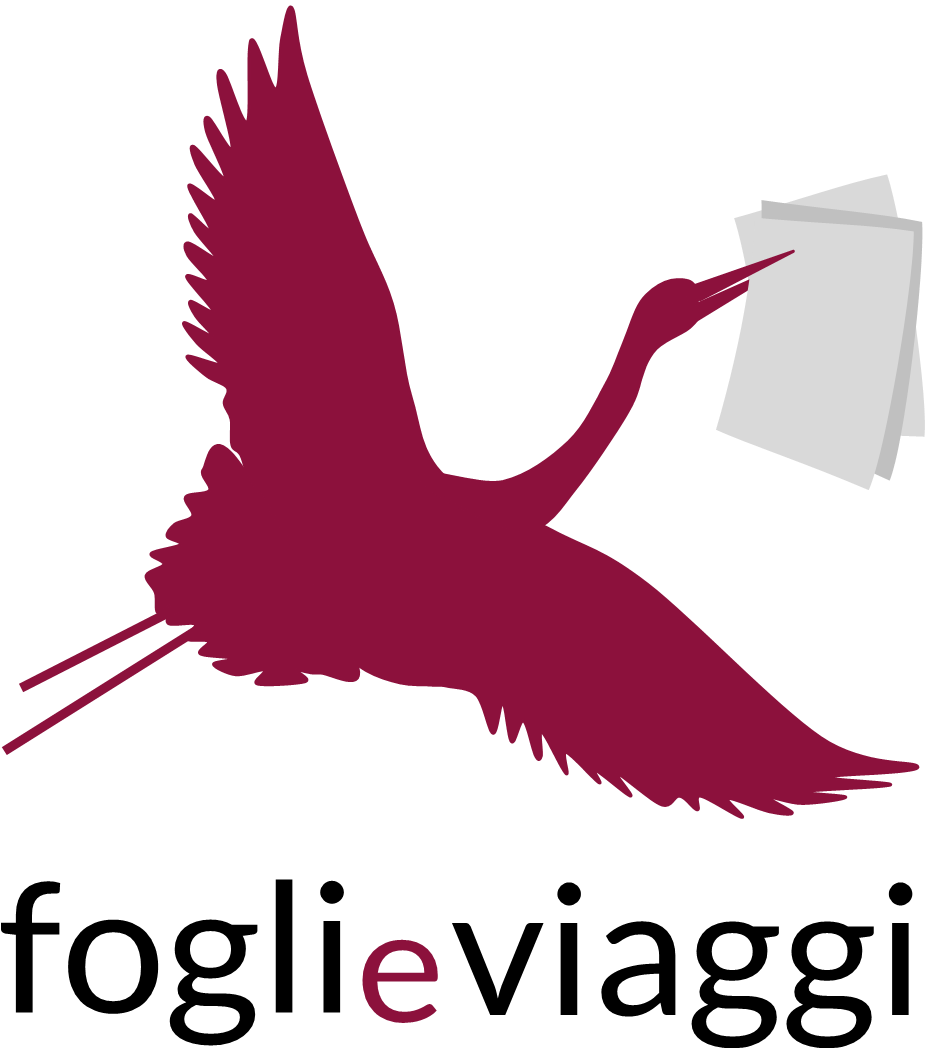Cilento fuori rotta, nelle gole del Calore / 2
di ANGELO MASCOLO*
«Vecenzella, Vecenzella te vulisse marità…»
Le parole della canzone scemano prima in un mugugno poi in un fischio leggero. Sotto la paglietta spostata su un lato della fronte mi appare il viso lungo e rugoso di un vecchio contadino. Schiena curva su una delle tre fontanelle che precedono di poche centinaia di metri l’ingresso a Felitto, un paesino di un migliaio di anime nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Lascio la macchina sul ciglio della curva e mi avvicino all’anziano signore per chiedergli un’informazione.
«Scusate» sfilandomi gli occhiali da sole «manca molto per le Gole del Calore?».
La risposta non
arriva subito. È preceduta da uno sguardo indagatore durante il quale l’uomo
mette in tensione ogni singolo filo di pelle. Una pantomima o forse una
reazione di naturale diffidenza per gente non abituata da queste parti a
incontrare molti forestieri. Alla fine, con una secchia di acqua che gli
allunga spalla e braccia al bacino, mi dice:
«Appena trase a lu paese» mostrandomi con
il dito asciutto il cartello “Benvenuti
a Felitto – paese del fusillo” «a
treciente metre a destra, truove na scritta e si arrivate».
Come se niente
fosse il vecchietto si rimette a fischiettare il motivetto della canzone. Solo
adesso ricordo dove l’ho sentito per la prima volta. Si tratta di uno stralcio
della Serenata di Antonio Ventura, un
poeta cantastorie originario di un paese poco distante da Felitto,
Sant’Arsenio. E me ne sono ricordato perché Pier Paolo Pasolini nel suo
Decamerone utilizzò varie strofe di questa ballata popolare come colonna sonora
alla sua rivisitazione delle novelle boccaccesche. Sarei tentato di continuare
il discorso con il contadino di Felitto, vorrei invitarlo a proseguire il suo
canto così asciutto e dolce. Ma temo che di Ventura, Sant’Arsenio e Pasolini
sappia molto poco.
Le indicazioni del contadino si rivelano più efficaci di Google Maps che a causa della connessione scadente era andata già in tilt all’imbocco della SS166, la Statale che attraversa i comuni principali della Val Calore: Roccadaspide, Castel San Lorenzo, Felitto per finire la sua corsa all’altezza di Atena Lucana, non lontano da Sala Consilina e dalla A3.
Il
parcheggiatore che mi accoglie nello spiazzo che sorge alle spalle dell’Oasi
del Calore è un uomo sulla trentina, con la canotte gonfiata dal ventre enorme
e la pelle sudaticcia. Bastano cinque minuti a piedi per trovarsi nella Gola
del Sacco, la principale delle sette Gole che scandiscono il percorso di 70 km
del fiume dalla sua sorgente posta sulle vette del Monte Cervati a quota 1900 metri fino al Sele, di cui il Calore Lucano, assieme al Tanagro, è uno degli
affluenti.
L’acqua che scava la roccia calcarea e che da millenni ha plasmato questi luoghi è verde rubino. Limpida, cristallina. Come lacrime divine piovute direttamente dal cielo. La natura è selvaggia anche se addolcita da quella stessa acqua a cui deve la forma. L’uomo non trova spazio in questo eremo. La sua presenza è sporadica, salvo per qualche escursionista coraggioso che si inerpica su uno dei due sentieri paralleli alla Gola per arrivare al ponte medievale posto a centinaia di metri sopra il livello del mare. Il verde è ovunque. Non solo nelle cascate e nei torrenti ma negli alberi, sulle foglie. Tutto ha una consistenza vitrea, infrangibile. Nei riflessi dell’acqua gelida – un bagno a 10° è una follia anche se molto tonificante per addome e gambe – ho l’impressione di rivedere tutto il Vallo di Diano. Come una fotografia che compendia tante immagini distinte: i paesini, le schiene morbide delle colline, gli ulivi, gli Alburni imponenti e, a sfumare in fondo, finanche il Monte Gelbison che gli abitanti del Vallo di Diano venerano come i napoletani il Vesuvio.
A separare il tratto del fiume, in questo punto, c’è una piccola chiusa. Sopra gli addetti del comune di Felitto hanno piazzato un avviso bilingue «Vietato tuffarsi/No diving». Ma quasi nessuno lo rispetta. Al contrario sono moltissimi, giovani e meno giovani, che si esibiscono in tuffi più o meno aggraziati. Altri, invece, bagnando il lato obliquo della chiusa lo utilizzano a mo’ di scivolo.
Il verde che tutto chiama a sé in questo luogo si impadronisce anche di questi corpi. Come piccoli ciottoli che cadendo in acqua mettono in scena spettacoli d’acqua improvvisati.
C’è un’ultima
immagine che questo luogo mi restituisce. Due occhi verdi. Della stessa
intensità dell’acqua del Calore. Occhi che mi guardano presentandomi un invito
a rimanere in questa terra, a non andare più via. Due occhi stupendi nei quali
perdersi per sempre.
*ANGELO MASCOLO (Sono archeologo, giornalista e scrittore. Ho collaborato con i quotidiani «Roma», «Metropolis» e «Il Mattino». Nel 2016 il mio romanzo "Palestra Italia" si è classificato secondo al Premio Letterario RAI «La Giara». A novembre 2017 è uscito «La primavera cade a novembre», giallo edito dalla casa editrice Homo Scrivens, arrivato alla seconda ristampa, che ha ottenuto diversi riconoscimenti a livello nazionale)
clicca qui per mettere un like sulla nostra pagina Facebook
clicca qui per rilanciare i nostri racconti su Twitter
clicca qui per consultarci su Linkedin
clicca qui per guardarci su Instagram